Dal blog “Il luogo fuori luogo” – 29 novembre 2011

Perché fuori luogo, potreste chiedervi.
Innanzitutto, perché andiamo ad abitarci, “fuori luogo”: in una casetta nei boschi, senza vicini, in una valle i cui abitanti fissi sono riassumibili in un numero di una sola cifra.
In una società abituata a considerare “luoghi” solo quelli dell’abitato, quelli odorosi di attività umane in fermento, in cui la vita scorre rapida e continua, andare ad abitare oltre i margini di tutta quest’attività equivale a perdersi nel nulla.
Ma l’idea è dovuta anche a un istante della mia vita, emblematico di molti altri istanti che mi e ci siamo trovati a vivere.
Dopo alcuni mesi di lavoro, sembrava che per me ci fosse la possibilità di ottenere un contratto a tempo determinato.
Io chiesi subito di ottenere un lavoro part-time. Fui convocata urgentemente all’ufficio contratti e sottoposta a interrogatorio: ricordo le tre segretarie sedute attorno a me, con espressioni sbalordite e un po’ infastidite, che mi chiedevano a ripetizione perché mai desiderassi un contratto part-time. Non avevo figli cui badare o altre esigenze familiari. Dunque, qual era il problema?
Cercai invano di spiegare loro che avevo intenzione di dedicarmi ad altre attività – che mi piaceva scrivere e che avrei voluto dedicarmi alla mia casa – ma loro rimanevano profondamente perplesse. Avevano l’aria di considerarmi una traditrice. Contraddicevo la loro immagine del giovane contrattista che pur di guadagnare più soldi è disposto ad ammazzarsi di lavoro.
Esprimere la volontà di guadagnare l’indispensabile e dedicare una fetta più grande possibile del proprio tempo a se stessi e ad offrire servizi gratuiti alla propria famiglia e alla società appare certamente fuori luogo. Infastidisce le coscienze.
So che il mio discorso potrebbe suscitare polemiche. Ci sono famiglie, anche in Italia, che vivono in povertà. Quella vera, che non è il potersi permettere solo un cellulare di pessima marca e non comperarsi il televisore al plasma. Il mio discorso non riguarda coloro che sono veramente poveri: riguarda tutti gli altri.
Il fatto è che persino chi non avrebbe bisogno di guadagnare cifre enormi per vivere sente il dovere di farlo. A meno di perdere… che cosa? La credibilità sociale, un ruolo, il potere, la stima di sè.
Noi non sentiamo questo bisogno. Il minimo ci basta.
Noi vogliamo restarci, fuori luogo.
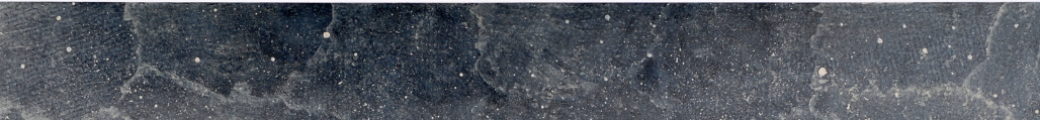
 Da piccola, nel giardino dei miei nonni, vivevo in una città d’alberi.
Da piccola, nel giardino dei miei nonni, vivevo in una città d’alberi. Andremo a vivere in una casetta nei boschi, comperata grazie ai frutti delle fatiche dei nostri genitori e ristrutturata grazie ai frutti delle nostre fatiche – i nostri stipendi e i nostri finesettimana degli ultimi due anni, trascorsi tra muri da abbattere e muri da costruire e TUTTO QUELLO che sta nel mezzo.
Andremo a vivere in una casetta nei boschi, comperata grazie ai frutti delle fatiche dei nostri genitori e ristrutturata grazie ai frutti delle nostre fatiche – i nostri stipendi e i nostri finesettimana degli ultimi due anni, trascorsi tra muri da abbattere e muri da costruire e TUTTO QUELLO che sta nel mezzo. Erano tempi chiari. Di fiori d’albicocco e soffioni, di rivelazioni sulle potature e scoperte sulla vita dell’orto.
Erano tempi chiari. Di fiori d’albicocco e soffioni, di rivelazioni sulle potature e scoperte sulla vita dell’orto. Che dire della nebbia, che cancella facendo rimanere, che fa il vuoto ma è piena di tutto. Un tutto che si svela all’improvviso, ed è già svanito prima di essere riuscito a stupirci fino in fondo.
Che dire della nebbia, che cancella facendo rimanere, che fa il vuoto ma è piena di tutto. Un tutto che si svela all’improvviso, ed è già svanito prima di essere riuscito a stupirci fino in fondo.







